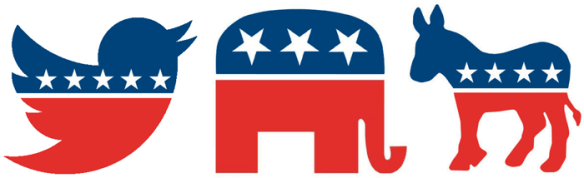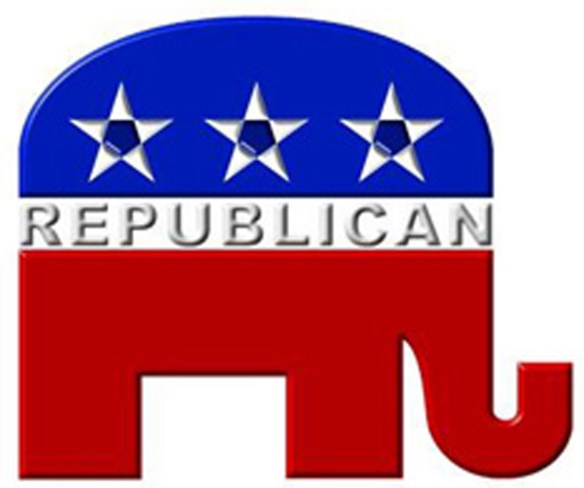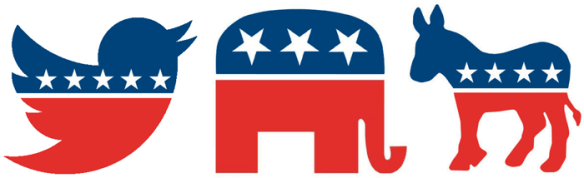
“La sua modestia come Presidente (Jimmy Carter, ndr) non è dovuta solo al suo carattere e alla sua preparazione, molta è colpa del sistema con il quale si elegge il Presidente. Se verrà eletto Reagan, avremo un caso simile a quello di Carter: non di dovrebbe imparare a fare il Presidente mentre lo si fa. Il sistema del primo ministro, adottato in altre democrazie occidentali, malgrado i suoi difetti costringe gli uomini che vogliono raggiungere il vertice ad un lungo apprendistato. Dovremmo evitare, almeno, che il capo dell’esecutivo sia scelto in base alla sua immagine”.
Così scriveva il politologo e storico statunitense James MacGregor (1918 – 2014), alla vigilia delle elezioni presidenziali del 1980.
In un periodo di forte, e per certi versi inedita, crisi del sistema americano, MacGregor individuava nell’affermazione della politica dell’immagine una delle cause dell’impasse nel quale versava il suo Paese. Per MacGregor, il “contenitore” aveva di fatto guadagnato il sopravvento sul “contenuto”, indebolendo e inquinando la cultura democratica e la sua prassi in modo pericoloso.
L’analisi, tuttavia, si basava su due modelli, James E.Carter e Ronald Wilson Reagan, per certi versi non appropriati, dal momento in cui entrambi si erano lanciati nella corsa alla Casa Bianca dopo una lunga gavetta come deputati e governatori (Carter della Georgia e Reagan della California).
Pur muovendo da due esempi “sbagliati”, la speculazione di MacGregor restava comunque intatta nella sua validità, per acquistare sempre più forza negli anni fino a trovare la sua definitiva conferma con Donald Trump; sprovvisto di qualsiasi esperienza politica sul “campo”, il magnate newyorkese è quindi un dilettante della politica, capace però di affermarsi in virtù della sua immagine, utilizzata come vettore principale ed elemento soverchiante rispetto ai contenuti, propri come altrui.