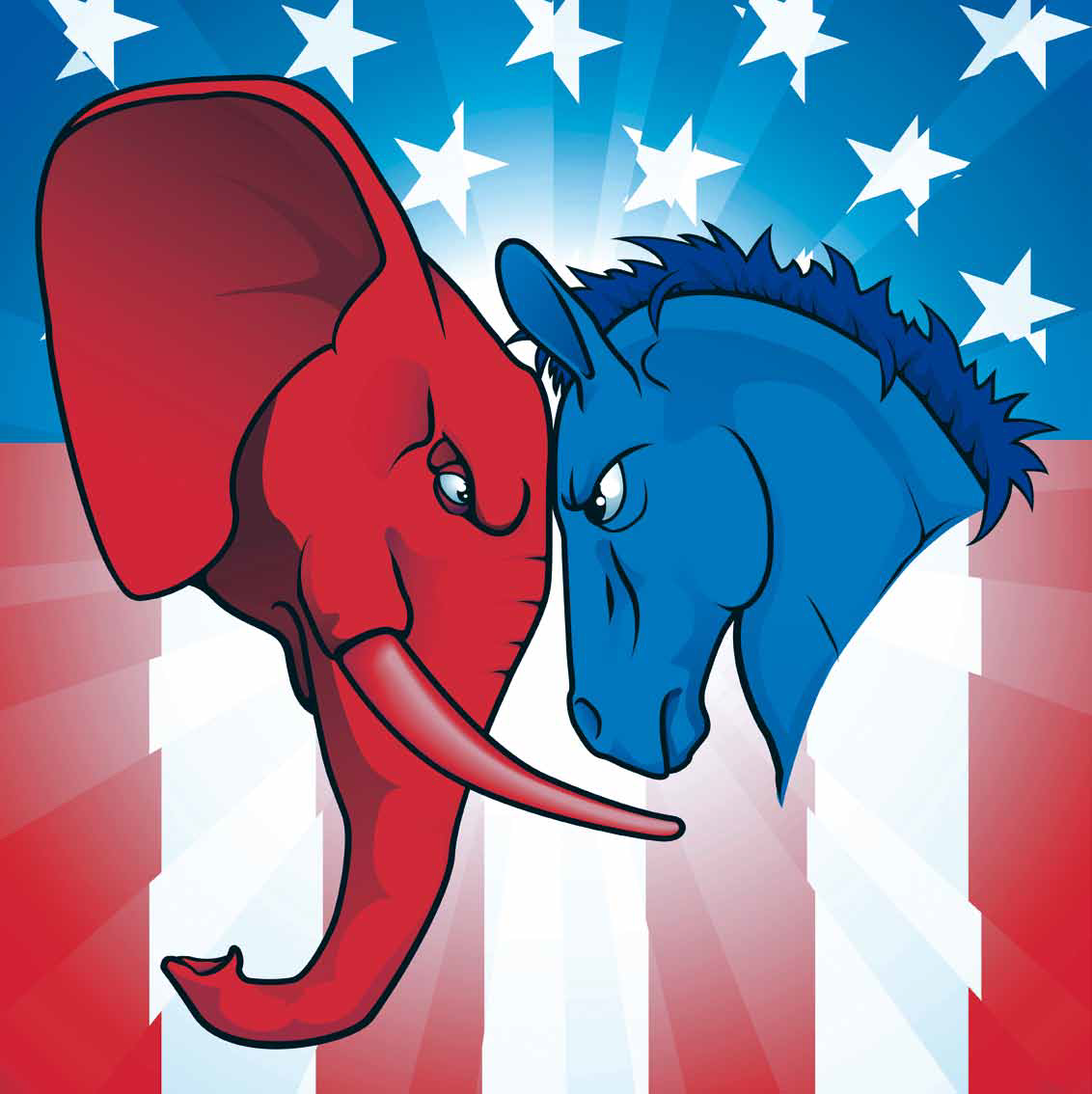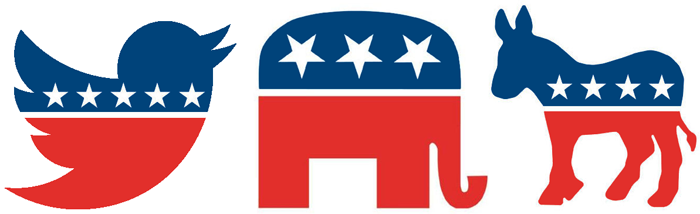Le ipotesi per spiegare il comportamento di Donald Trump dopo il voto sono molteplici, ad esempio ribaltarne l’esito per via politica o giudiziaria, preparare il terreno per il 2024, ottenere delle immunità o il semplice e “banale” orgoglio personale.
Da un punto di vista strategico, comunicativo e propagandistico, il “tycoon” potrebbe ad ogni modo star seguendo un passaggio del “codice del dominio” (da lui usato a piene mani), ovvero stressare ed esasperare la situazione fino a portarla vicino al limite di rottura, così da volgerla a proprio favore.
Ma come?
Vicino al limite di rottura, appunto, ma ritirandosi in tempo, dando l’impressione di fare, lui, delle aperture, di trattare, lui, da un punto di forza. In questo caso riprenderebbe in parte anche il cosiddetto “Equilibrio di Nash” (teoria dei giochi), in cui i “players”, trovatisi in un momento di stallo, devono giocoforza fare delle concessioni agli altri per uscire dall’impasse e ottenere un risultato.
Quale sia questo risultato, per “The Donald”, lo chiariranno i prossimi mesi.